
Grand Tour
Tutti i siti UNESCO piemontesi in un’unica traccia: un filo conduttore, lungo oltre 600 km, dove natura, storia e architettura si fondono, in un paesaggio straordinario.
Periodo consigliato
Mar - Nov
Dislivello Totale
6661 m
Lunghezza totale
661 km
Durata
7/10 Giorni
Q
Ci siamo poi accorti che, più che puntare dritto alla destinazione, quello che ci piace davvero è pedalare tra i luoghi considerati così belli. Pensando che lo spazio intermedio non è vuoto, ma semplicemente pieno di cose diverse, anche se meno importanti, in assoluto. È proprio questo vuoto che cerchiamo: una vacanza per staccarsi dalle cose di tutti i giorni, per vedere il mondo con occhi nuovi. Scegliere il margine, l’inatteso, la strada sterrata invece di quella asfaltata. Lasciare che il paesaggio ci entri dentro per incorporarlo con la fatica, che rende gli occhi più attenti e capaci di farci vedere meglio le cose, di comprenderle oltre le apparenze e, proprio come si dice, al di là dei luoghi comuni. Luoghi che si attraversano solcandone la superficie, ma dove di tanto in tanto ci si può fermare per guardare in profondità, per leggere-dentro alle pieghe più nascoste del paesaggio, di intus-legere, per capire, come dicevano i romani. Lasciare spazio al tempo e al silenzio, rallentare per ascoltare i luoghi minori, piuttosto che correre per raggiungere chi grida più forte. Soprattutto in questi anni in cui il fenomeno dell’overtourism porta a snaturare la bellezza di molti luoghi, rendendoli di fatto inaccessibili.


Nella memoria, che il viaggio ci ha letteralmente fatto incorporare, rimangono allora impressi ambienti, paesaggi, vedute panoramiche, boschi e pianure, piccoli borghi da attraversare, chiesette di campagna ma anche un pilone votivo all’incrocio tra due strade di campagna, un caffè o una pasticceria sotto i portici di un centro storico o un albero monumentale che sotto le sue fronde ha visto passare la storia del Piemonte, così come tra i muri di una fabbrica, lungo le sponde di un canale o in un museo di arte contemporanea. Una storia che ci fa guardare al paesaggio non solo attraverso gli ambienti e i panorami, ma anche interpretandolo in chiave contemporanea. Un connubio equilibrato tra passato e tradizione, ma dove si possono anche cogliere segni di futuro e innovazione.
Noi siamo partiti da Torino con l’idea di percorrere l’anello in senso orario: non sappiamo bene il perché di questa scelta, forse volevamo solo pedalare per un bel po’ con il sole in faccia la mattina, e chiudere il giro verso Ovest, guardando il sole che va giù, rincorrendo l’ultima birra dopo una salita fatta con il cuore in gola. Partire e arrivare a Torino è di certo comodo, in treno o in aereo. Ma soprattutto, è bello attraversare la città partendo proprio dal Po, che scorre ai piedi della Collina, Riserva dell’Uomo e della Biosfera, tra l’altro anche riconosciuto dall’UNESCO. Come anche le Residenze Reali che affacciano sul fiume, con i castelli di Moncalieri e del Valentino, la Villa della Regina. Bello attraversare il centro di comando con la Cavallerizza, Palazzo Carignano e Palazzo Reale. E magari, prima di partire davvero, salire ancora come abbiamo fatto noi al Monte dei Cappuccini, da dove si può abbracciare con la vista quasi la metà del percorso e riconoscere alcuni luoghi che poi raggiungeremo o che vedremo da vicino durante il viaggio, come il Monviso, le montagne olimpiche, la Sacra di San Michele e il Rocciamelone, le valli di Lanzo, il Gran Paradiso e il Monte Rosa.


Finalmente in sella, siamo passati letteralmente attraverso le romane Porte Palatine, per seguire la Dora Riparia e poi la Stura fino a Venaria. La natura dei fiumi, la storia dell’industria, gli scorci sulle montagne del Piè Monte: il DNA della Regione sta quasi tutto qui, in pochi chilometri. Quale migliore anticipazione dei tanti luoghi che poi ritroveremo lungo i 650 chilometri che andremo a percorrere?
Sgusciamo in fretta fuori dal centro, senza farci distrarre troppo da caffè, pasticcerie, vermouth e bicerin vari e seguiamo il fiume, passando per il Mercato di Porta Palazzo, per fare giusto un po’ di scorta di frutta secca in una meravigliosa drogheria nascosta dietro ai banchi. Entriamo subito nel mood giusto passando per il Parco Dora: fiumi, canali, fabbriche, orizzonti aperti verso le montagne che abbracciano Torino e che ci orienteranno nei prossimi giorni, da Nord a Sud.


Lasciati i terreni boscosi e asciutti delle Vaude, arriviamo veloci sul torrente Orco a Cuorgnè, con i suoi bei portici, la monumentale fabbrica della Manifattura, affacciata sul fiume e, dopo pochi chilometri, sullo stradone tocchiamo Castellamonte con fare distratto perché puntiamo dritti a uno dei tratti che ci piacciono di più: lo sterrato che segue il Canale di Caluso al margine della collina, tra boschi e spazi aperti, che ci porta dritti al Castello di Agliè, passando per la fabbrica Olivetti dove si produceva la mitica lettera 22. Lasciamo il canale e saliamo al borgo e al Castello di Agliè, dove si può anche pedalare all’interno del parco, per poi spostarsi verso le colline a Nord, passando a fianco di Villa Il Meleto, cara a Guido Gozzano. Qualche saliscendi tra borghi e ricetti sulle colline ai piedi di valli belle e nascoste come la Valchiusella, per arrivare fino a Colleretto Giacosa.
La campagna tra l’altopiano delle Vaude e le colline ci avvicina rapidamente agli splendidi vigneti dell’Erbaluce, nel pieno del grandioso Anfiteatro Morenico di Ivrea: uno degli spot migliori per scorrazzare su infinite strade sterrate, tra torrenti e laghi lasciati in regalo dal grande Ghiacciaio Balteo, che fino a 10.000 anni fa arrivava proprio qua, scendendo dalla Valle d’Aosta, regalandoci anche la collina morenica della Serra, perfettamente rettilinea e che rende riconoscibile in modo unico il paesaggio della pianura tra Biellese e Torinese.
La risaliremo domani, perchè Ivrea merita di certo una sosta, anche solo per avere un’idea più completa dell’opera di Camillo e soprattutto di Adriano Olivetti, l’imprenditore visionario che, in anticipo di almeno cinquant’anni, vedeva Ivrea come la città dell’uomo, al centro di un paesaggio nuovo: architettura, urbanistica, casa, fabbrica e campagna fuse in un sistema che ancora oggi possiamo ammirare: caso unico ed esemplare di Città Industriale del XX secolo.


Lasciamo Ivrea lungo la Via Francigena, passando per il lago Sirio, attraverso un dedalo di vie sterrate e single track, che evitano le strade più trafficate portandoci con qualche fatica fino ad Andrate, a circa 800 metri di quota. Da qui, inizia la superlativa balconata che attraversa tutte le alpi Biellesi, dalla valle della Dora Baltea fino alla valle della Sesia lungo sessantacinque chilometri di strada di montagna affacciata sulla pianura tra Torino e Milano. Noi la percorriamo da Andrate fino al Bocchetto Sessera, passando lungo quello che tutti conoscono come il Tracciolino fino a Oropa, per scendere fino a Biella.
Un posto dove a ogni curva che si sporge verso la pianura ti viene voglia di stendere il materassino per dormire alla belle-étoile, per aspettare il tramonto o l’alba guardando appunto le stelle; ma ci aspettano Giuseppe e Nazarena, i custodi attenti di un posto davvero speciale: l’antico monastero della Trappa.


Qui ci siamo fermati per la notte, nelle piccole essenziali stanze che ospitano i pellegrini, proprio di fronte alla monumentale Porta Regia. Il silenzio della sera e il tramonto sulla pianura sono i ricordi più forti che questo viaggio ci ha lasciato. La strada a questo punto offre l’opzione di scendere a Biella lungo il percorso abbandonato del vecchio tramway e il parco della Burcina – se ci passate a maggio, non perdete le famose fioriture dei rododendri –, per risalire dalla magnifica valle del Cervo, oppure proseguire verso la galleria di Rosazza e il Santuario di San Giovanni di Andorno, arrivando direttamente nella valle del fiume Cervo a Campiglia.
Noi siamo scesi a Biella, abbiamo visitato il borgo del Piazzo, il bel centro storico e gli spazi post-industriali lungo il fiume Cervo della Fondazione Pistoletto Cittadellarte e del complesso dell’ex lanificio Maurizio Sella, con le sue attività tra innovazione e conservazione della memoria storica della famiglia Sella, tra imprenditoria, politica, amore per il paesaggio e montagna. Da qui siamo risaliti per la valle, godendoci un bagno rinfrescante in una lama, come chiamano qui le piscine naturali, ottime anche per la pesca.
Passato Campiglia abbiamo attaccato la strada che tutti chiamano Panoramica Zegna e che sale verso Bielmonte con scenografiche vedute verso la pianura e il Monviso. Arrivati al Bocchetto Sessera siamo scesi sull’altro versante, puntando a un’altra Bocchetta, quella della Boscarola. Da qui passa la faglia che separa nientemeno che la zolla africana da quella europea, un posto unico per i geologi di tutto il mondo, che abbiamo seguito fino al nostro arrivo in Valsesia.
Da Scopello abbiamo seguito per i primi venti chilometri una bella parte delle sponde più incassate del fiume, lasciando alle spalle il Monte Rosa – la Chimera, come la chiamava lo scrittore Sebastiano Vassalli – seguendone il corso e uscendo nella piana di Varallo. Cena veloce in una terrazza affacciata sulle montagne, alle spalle del Sacro Monte patrimonio UNESCO, dove Elena ed Enrico ci aspettano per svelarci i segreti di questo capolavoro, risultato di un connubio straordinario tra paesaggio, architettura e fede. Il centro storico è anche un ottimo punto di partenza per scoprire un altro luogo UNESCO, il Geoparco Sesia-Val Grande, dove ancora oggi sono presenti le tracce del Supervulcano rese visibili grazie al lavorio dei ghiacciai e all’erosione dei fiumi, come se fosse una radiografia della terra che evidenzia la successione delle ere geologiche.
È un nuovo giorno ed eccoci di nuovo in sella, a pedalare lungo le sponde del fiume per più di sessantacinque chilometri. All’inizio tra borghi e canali, poi su sterrati degli argini del Sesia in leggera discesa, dentro a boschi di querce, carpini e pioppi. Solo la ricerca di una fontanella d’acqua ci ha portato a uscire da questa meraviglia, raggiungendo uno di quei posti che si trovano solo in certi angoli della Pianura Padana con tanto di trattoria con pranzo a prezzo fisso: 10 euro bevande incluse. È incredibile: siamo proprio al centro dell’Europa, letteralmente, dove si incrociano come moderni cardi e decumani i due corridoi che attraversano tutto il Vecchio Continente e che collegano Kiev con Lisbona e Rotterdam con Genova.
Qui scorrono anche le acque del Canale Cavour, in uno spettacolare sifone che passa sotto al fiume Sesia. Trovarsi qui in bicicletta, su una magnifica sterrata nel silenzio del fiume e protetti dal rombo dei tir e dei treni ad alta velocità che sfrecciano a poca distanza, è un’esperienza davvero unica.


Ci accorgiamo che le infrastrutture – ferrovie, strade, autostrade – che appartengono alle reti veloci e lunghe delle vie di comunicazione, alla fine sono parenti strette di altre infrastrutture, anche loro lunghe ma di certo più lente, come il canale Cavour e la via Francigena. Tutte insieme attraversano quello che mi piace pensare come una sorta di Central Park, straordinario spazio che si può raggiungere in poco più di mezz’ora di treno dalle città del vecchio triangolo industriale e che è oggi un paradiso per il bikepacking e per le biciclette di ogni genere.
Non possiamo a questo punto mancare un giro per Vercelli, nel centro storico, arrivando dai viali che lo circondano come quello intitolato a Garibaldi – appena trasformato in un bel parco urbano – che porta alla Stazione. Una veloce occhiata alla Basilica di Sant’Andrea e una sosta in piazza Cavour, dove optiamo per un gelato che da solo vale l’intero viaggio e che ci fornisce le energie per ripartire, ormai in vista delle colline del Monferrato.


Una immersione nel giallo che ci porterà fino al Po. Un paesaggio produttivo, dove tutto è strettamente connesso con le risorse naturali: oggi frutto del lavoro millenario dell’uomo, fatto di risaie e di canali ma anche di colline di marna, che si cavava al di là del fiume e che veniva trasformata nei cementifici. Quello di Trino è stato recentemente trasformato in un museo davvero speciale, che tiene insieme le attività produttive ancora attive, l’archeologia industriale e l’arte contemporanea.
Percorriamo l’argine del Po fino alla città di Casale, un tesoro nascosto, la vera e propria porta del Monferrato. Da qui, lasciati i monumenti e le attività dell’industria del cemento che sta restituendo nuovi spazi e architetture per la città e per il suo sviluppo turistico, risaliamo le colline. Passiamo da punti panoramici a strade bianche, borghi e monumenti della storia dell’industria italiana, come le fornaci di Ozzano e il castello di Cereseto voluto da Riccardo Gualino. Raggiungiamo il Sacro Monte di Crea patrimonio UNESCO, scendiamo su Moncalvo e arriviamo ad Asti, sempre accompagnati dalla brezza del pomeriggio, sul filo di cresta delle colline.
Anche Asti è una meraviglia di tesori, ma dobbiamo andare veloci attraverso il centro storico, con la certezza che ci torneremo con la dovuta calma. Prima di lasciare la città, ci fermiamo però nel perfetto giardino della caffetteria del Museo Mazzetti: almeno il tempo per un caffè, prima di affrontare le salite, dolci e tranquille, che ci portano sulle colline che stanno alte sulla valle del Tanaro. È la parte che preferiamo, per guardare da lontano quella molto frequentata del Barolo e del Barbaresco sull’altro versante. Noi le abbiamo attraversate passando per San Martino Alfieri, la Residenza UNESCO di Govone, il borgo di Guarene, lasciandole solo per scendere infine sulla città di Alba. Qui ci fermiamo per la notte, ma lo stesso avremmo potuto fare, se avessimo avuto ancora energia da mettere nei pedali, a Pollenzo oppure a Bra, che distano solo una ventina di chilometri. Insomma, ogni luogo meriterebbe una cena e una notte.
Il giorno seguente corriamo sugli argini del Tanaro e lungo le alzaie del canale di Verduno. Ci affacciamo per un ultimo sguardo sul fiume alla spiaggia dei Cristalli, ci mettiamo veloci sui pedali con le luci accese e le spalle strette, per il breve tratto sulla strada trafficata che attraversa il fiume e ci fa entrare nel borgo di Pollenzo con il suo Castello sito UNESCO e l’importante complesso dell’Università di Scienze Gastronomiche. Ci rimettiamo in strada tra gli orti, lontano dalla statale, e arriviamo in breve a Bra: il luogo migliore per una sosta. Il movimento Slow Food è nato qui, non per caso, e in effetti la cultura del cibo buono e giusto si percepisce in ogni locale e negozio di questa bella cittadina. Abbiamo concluso così un tratto unico, da Casale a Bra, dove il Tanaro è la spina dorsale di un territorio interamente dedicato alla cultura del vino, che Mario Soldati, nel suo strepitoso viaggio nei paesaggi italiani, raccolti nel libro Vino al vino, ha descritto come l’asse maggiore di una specie di ellissi che va da Moncalvo a Dogliani, dove i vini sono in rapporto stretto non solo con la geologia dei terreni, ma anche e soprattutto con la loro posizione rispetto al sole fresco del mattino – Grignolino, Barbera, Nebbiolo, Arnèis, Freisa – sulla sponda sinistra del Tanaro, rispetto a quello più caldo delle ore del tramonto – Barolo, Barbaresco, Dolcetto, Moscato – alla destra del fiume.


Ripartiamo belli tonici e attraversiamo la campagna per raggiungere Racconigi con il castello e il magnifico parco, patrimonio UNESCO. Lasciamo il bel centro storico tra le archeologie industriali di canali e setifici che segnano la campagna. Riusciamo a stare sulle sponde del fiume Maira. Un single track tecnico ma continuo ci fa pedalare contenti come bambini, all’ombra dei boschi fino a Savigliano. Qui andiamo a colpo sicuro in piazza Santorre di Santarosa, con una sosta obbligatoria nella pasticceria sotto i portici, per l’aperitivo tipico: il mitico Paulin, custodito come un segreto, che ci fa riprendere la strada felici, attraversando una campagna tra frutteti, con il tramonto in faccia alle colline di Saluzzo e il Monviso a fare da sfondo.
Passeremo la notte in questa meravigliosa cittadina e anche qui non possiamo che dire che dovremmo fermarci almeno un paio di giorni, ma ci attende un altro luogo epico: l’Abbazia di Staffarda, che raggiungeremo attraversando il Po su un guado – sì, il maggiore fiume italiano è spesso completamente asciutto nella campagna a valle di Saluzzo.


Continuiamo per la campagna che si fa più movimentata, di tanto in tanto su qualche collina, seguendo la strada della pietra, tra Barge e Bricherasio, sotto le pendici del Monte Bracco, il Mombracho che già conosceva Leonardo da Vinci. Pedaleremo puntando a quella particolarità geologica che è la Rocca di Cavour, una montagna-isola o inselberg, come dicono i geologi. Qui capitiamo durante il giorno di mercato, che si tiene all’ombra dell’antico spazio coperto. Pasteggiamo a vino, formaggio, una pesca e un gelato artigianale per dessert: what else? Lasciamo il borgo e la campagna circostante con le magnifiche ville a Campiglione. Percorrendo un bel tratto della ciclabile sulla vecchia ferrovia fino a Bricherasio, passiamo dal Castello di Miradolo, per raggiungere finalmente Pinerolo. Ennesimo meritatissimo gelato, prima di ripartire verso la Valle di Susa che raggiungeremo ad Avigliana, con i suoi due laghi. Il tempo è asciutto e possiamo approfittare del single track lungo la sponda occidentale del Lago Piccolo, per poi superare il Lago Grande e risalire al bel borgo arroccato dove è possibile passare la notte nell’ottimo ostello con ciclocucina incorporata.


Il viaggio si avvicina al termine. Ci sentiamo già riconnessi alla città: da qui si sente la presenza di antiche, nuove e nuovissime vie di comunicazione: la via Francigena, la ferrovia del Frejus, l’autostrada, i cantieri dell’alta velocità che ora riusciamo a vedere in relazione con alcuni luoghi che abbiamo toccato pochi giorni fa, tra il Canale Cavour e l’autostrada per Milano. Anche qui siamo in un grande crocevia che ci insegna, ancora una volta, che passato, presente e futuro possono coesistere: con questo spirito passiamo Sant’Antonio di Ranverso, strepitoso luogo di culto lungo le antiche vie di comunicazione e il Castello di Rivoli, con il suo museo, luogo dell’arte contemporanea, che anticipa il futuro.
Possiamo rientrare tranquillamente, seguendo per lunghi tratti le sponde del fiume Dora e puntando al centro, zigzagando, come in tutte le città, per evitare svincoli, fabbriche e centri commerciali fino al Parco della Pellerina che, anche nel nome, mantiene la memoria degli antichi pellegrinaggi. Ritorniamo così di nuovo al Parco Dora, che ci accoglie, nel cuore della città post industriale sempre in cerca di nuove vocazioni, tra storia, fabbrica e una natura che sta riconquistando nuovi spazi. Al termine di questa magnifica avventura rimangono nel corpo, negli occhi e nella mente tanti luoghi come fossero parole di un racconto: il paesaggio piemontese è la nostra personale via dei canti. Un vero e proprio libro da sfogliare, da leggere, ma in buona parte ancora da scrivere.

Testi
Andrea Rolando

Foto
Paolo Penni Martelli
Hanno pedalato con noi
Jacopo Chianale, Rebecca Fruttero
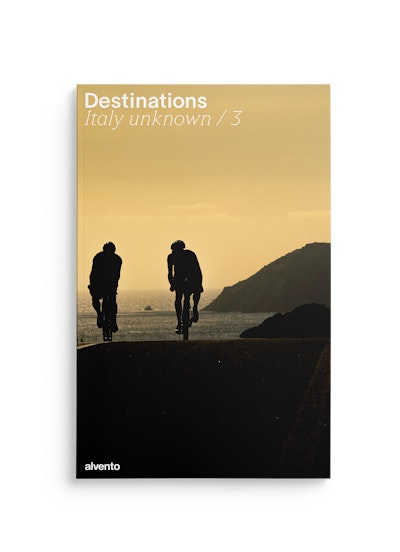
Questo itinerario lo puoi trovare sul super-magazine Destinations – Italy unknown / 3, lo speciale di alvento dedicato al bikepacking. 9 destinazioni poco battute o reinterpretazioni di mete ciclistiche famose.

















