
Il balcone delle Alpi
Il cuore del Central Park tra Torino e Milano. Un territorio che stupisce per varietà di proposte paesaggistiche e riferimenti storici.
Dislivello Totale
3518 m
Lunghezza totale
196 km
Durata
2/3 Giorni
S
Il balcone delle Alpi
00
Intro
01
Tra Biella e Rosazza lungo il torrente Cervo
02
La Panoramica Zegna
03
Il paesaggio del vino tra Masserano, Lessona e Castellengo
04
La Baraggia tra Castellengo e Masazza
05
Le risaie tra Masazza e Salussola
06
Le colline della Bessa e del cordone morenico della Serra
07
La Strada Panoramica Zegna tra Andrate e Oropa
08
La discesa verso Biella per il parco della Burcina
Sono le montagne che fanno da sfondo al Biellese, e che si sviluppano tra due monti che, curiosamente, portano lo stesso nome di Mombarone (baron, in piemontese, significa mucchio).
A ovest, sopra Ivrea, è il Mombarone di Andrate, a est quello di Coggiola, all’imbocco della Valsesia. In mezzo, valli, colline e strade panoramiche, borghi e boschi.


Certo, per godersi tutto ci si dovrebbe fermare quasi a ogni posto che attira la nostra curiosità, ma il nostro obiettivo è di coprire l’itinerario in tre giorni e ci tocca stare in sella e pedalare.
E allora risaliamo la Valle del Cervo, seguendo in senso orario una traccia che ha la forma di un cuore, che da Biella sale ad arco verso le montagne, scende fino alla pianura delle risaie e poi percorre un altro grande arco panoramico tra le colline della Serra fino a Oropa, per ritornare nel capoluogo, dopo 210 chilometri e quasi 4.000 metri di dislivello, in gran parte su sterrati, sentieri e anche su strade asfaltate, ma sempre lontano dalle strade più trafficate.
A Biella partiamo dopo un caffè e un canestrello al cioccolato, in uno dei locali lungo la via Italia, tra portici e negozi. Alla fine del centro storico passiamo a fianco di una delle più antiche e famose fabbriche italiane di birra: è il vecchio quartiere industriale.
I grandi opifici lungo il fiume sono la testimonianza delle vicende di Quintino e di Vittorio Sella, dei Fila, dei Cerruti e di altre famiglie di imprenditori che hanno fatto la storia dell’industria tessile; ora in parte trasformati in contenitori per l’arte contemporanea e per l’innovazione, sono luoghi che intrecciano fare e saper fare, tra produzione, cultura e sperimentazioni di un nuovo futuro ancora da inventare.
Risalendo il corso del Cervo, grandi fabbriche poste sul greto del fiume continuano a segnare il paesaggio: acqua, terra e telai. Ci infiliamo lungo strade secondarie che attraversano la valle su stretti ponti e che toccano piccole magnifiche borgate come Miagliano, Sagliano, Oretto, Sassaia, Campiglia, Rosazza. Al solo passaggio vi si scorgono originalissime architetture in pietra. Marco e Massimo, ciclisti e geologi che pedalano con me, vanno spediti, ma intanto mi raccontano dell’importanza geologica del Biellese: da qui passa una linea di demarcazione tra due zolle tettoniche, tra Africa ed Europa e da qui viene estratta la sienite della Balma, la pietra sulla quale poggia nientemeno che la Statua della Libertà di New York. Sfioriamo Andorno, il paese del Ratafià, e Campiglia, dove nella parrocchiale c’è un bellissimo polittico, ma poi ci fermiamo per un rapido bagno in una delle strepitose piscine naturali del Cervo, che continua ad accompagnare la nostra strada: l’acqua è cristallina, ma non è proprio quella termale…
La strada si stacca dalla Valle del Cervo e risale verso il Bocchetto Sessera per poi scendere su Trivero. È una delle strade più spettacolari che si possano fare in bicicletta, con panorami aperti verso tutta la pianura del Po, dal Monviso verso Torino, Vercelli, Novara, fino ai grattacieli di Milano, passando per il profilo del Monte Rosa. Noi l’abbiamo percorsa al tramonto di una giornata estiva, ed è un’esperienza che difficilmente dimenticheremo. Ma se ci tornate in primavera sarete catturati dalle fioriture dei rododendri o dei narcisi, mentre in autunno saranno i colori del foliage a incantarvi. Ricordatevi, magari per un’altra occasione, la variante che dalla Panoramica s’inoltra in Val Sessera, verso l’alpe di Mera, attraverso la bocchetta della Boscarola: un magnifico playground, apprezzato da carbonici attillati ciclisti in lycra e gomme da 25, ma anche da sciolti appassionati del downhill più tecnico, con la braga molle d’ordinanza.


Lasciato alle spalle Bielmonte, una lunga e bella discesa porta a Trivero passando attraverso altri luoghi dell’Oasi Zegna (Conca dei Rododendri, Centro e Casa Zegna) voluti da Ermenegildo Zegna con l’aiuto di architetti e paesaggisti come Luigi Vietti e Pietro Porcinai, e oggi ancora amorevolmente curati dalla stessa famiglia d’imprenditori. In uno degli ultimi tornanti una sosta per una buona birra artigianale è d’obbligo. Da queste parti si trova anche facilmente da dormire, in uno dei tanti agriturismi e alberghi dell’Oasi. Dopo più di 50 chilometri e 1.500 metri di dislivello, ce lo meritiamo.
Il giorno dopo ci rimettiamo in sella e continuiamo a scendere verso la pianura, passando per Castagnea – dove c’è l’interessantissima fabbrica-museo della Ruota a Pray – e per il borgo di Mezzana Mortigliengo, con un museo a cielo aperto di arte contemporanea.
La strada serpeggia tra salite, discese e tratti più tranquilli; si incrocia qualche tratto della gran fondo della Prevostura, dove ci imbattiamo di tanto in tanto in tribù di downhillers che incidono il terreno lungo i molti percorsi delle Rive Rosse.
Dopo una sosta alla bella chiesa di San Teonesto a Masserano, riprendiamo le strade acciottolate di questo piccolo magnifico borgo, per puntare verso le colline vitate di Masserano e Lessona. Ci troviamo in una zona di eccellenza vitivinicola, descritta anni fa dallo scrittore e buongustaio Mario Soldati, che a questi luoghi – ancora molto da scoprire, ma senza esagerare… – ha dedicato memorabili pagine nel suo libro Vino al vino. Due vini, in particolare, sono strepitosi: il Lessona e il Bramaterra.


E allora ci spingiamo fino a toccare uno dei luoghi più nascosti e sorprendenti del nostro viaggio: le scenografiche sponde sabbiose, poco a valle della confluenza con il torrente Strona. Si tratta di poco più di un chilometro dove pedaliamo in equilibrio sul single track sospeso sopra un canyon spettacolare scavato in profondità dal fiume. Un consiglio: evitate di passarci in caso di forti piogge.
Guadato il fiume nei pressi di Castelletto Cervo, il percorso continua a zig-zag tra campi, cascine e chiese – quella dei Santi Pietro e Paolo tra Mottalciata e Castellengo, con i magnifici affreschi, merita una sosta – e si raggiunge un altro luogo del vino e dell’ospitalità al castello di Castellengo, che segna il paesaggio tra la pianura e le prime colline.
Pochi tornanti e si entra in un altro ambiente strepitoso, quello del grande terrazzo fluviale della Baraggia. È un esteso altipiano di terreno argilloso, sospeso tra i torrenti Cervo ed Elvo, completamente disabitato e caratterizzato da ampie radure prative spesso coperte di erica e radi boschi di betulle e querce. Fino a non molti anni fa, la parte meridionale era inaccessibile e riservata a esercitazioni militari, ma oggi le giornate di chiusura sono limitate e pochi giorni all’anno. Lo percorriamo per 18 chilometri quasi completamente pianeggianti, su strade sterrate e single track che, da soli, valgono l’intero viaggio, con orizzonti apertissimi e scorci magnifici sulla montagna. Anche qui, attenti al fango e alle pozzanghere, ma ci potete venire in tutte le stagioni dell’anno, anche nelle giornate più fredde dell’inverno. Noi ci arriviamo quando le ombre del pomeriggio si allungano sul terrazzo sospeso a quasi 100 metri sopra al greto del torrente Cervo, vicino ad una grande quercia: ci fermiamo un attimo e con soddisfazione ammiriamo la strada fatta, il grande arco che abbraccia tutto il Biellese orientale.
Da qui, volendo, si può già rientrare a Biella, seguendo il terrazzo del fiume Cervo e visitando il borgo e il Ricetto di Candelo: è un’opportunità per chi ha solo due giorni di tempo. Ma noi puntiamo il manubrio verso Sud e, tra spazi aperti e radi boschi di betulle, dopo una decina di chilometri, arriviamo a Masazza, dove ritroviamo la pianura e riprendiamo a muoverci tra cascine e lunghi rettifili che attraversano le risaie della parte meridionale del nostro anello. Arriviamo a Salussola (stazione ferroviaria lungo la linea Santhià-Biella), attraversiamo l’Elvo, il secondo corso d’acqua che segna il paesaggio del Biellese e riprendiamo a salire dolcemente verso Cerrione, mettendo nel mirino le montagne che attraverseremo nell’ultimo tratto dell’anello, tra il Mombarone di Ivrea e il Santuario di Oropa. Possiamo fermarci da queste parti per la notte: abbiamo fatto altri 70 chilometri e anche se con molte discese, 1.000 metri di dislivello nelle gambe e non pochi sterrati.
Tornati in sella, riprendiamo in quota verso la Riserva Speciale della Bessa. Qui un tempo c’erano miniere d’oro, sfruttate fin dall’epoca romana. Hanno lasciato segni evidenti nel paesaggio: grandi cumuli di sassi e conoidi di accumulo dei materiali lavorati per l’estrazione. Lungo sentieri single track e piccole strade sterrate, quasi sempre all’ombra del bosco, che ci protegge perfettamente dal caldo dell’estate, tocchiamo i borghi tra Sala, Zubiena e Magnano.
Chi vuole da queste parti può regalarsi una duplice sosta: per il corpo, in qualche negozio a comprare i calorici torcetti della Serra; o per l’anima, facendo visita al ricetto e alla chiesa di San Secondo a Magnano, presso la comunità di Bose.
Stiamo risalendo il lungo cordone morenico della Serra. Paolo insiste perché la percorriamo tutta, fino ad Andrate, dove iniziano le pendici del Mombarone e lo spartiacque tra Biellese e Valle d’Aosta si eleva oltre i duemila metri di quota. La geografia non si discute: non basta solo descriverla a parole o nelle carte, bisogna conquistarla anche con fatica e incorporando il paesaggio per fissarlo nella memoria. Per questo cerchiamo di stare proprio sul filo di cresta, con l’idea di disegnare, ricalcandolo, proprio il profilo lungo più di 10 chilometri della Serra, quella dorsale quasi perfettamente rettilinea che si scorge facilmente dal finestrino del treno e della macchina viaggiando tra Torino e Milano.
Arrivati in cima alla Serra, ad Andrate, puntiamo verso Oropa e riprendiamo il tracciato della strada Panoramica che Ermenegildo Zegna, illuminato imprenditore tessile, aveva immaginato come un filo di lana capace di cucire e tenere insieme i tanti luoghi e temi identitari per l’intero territorio: la natura, i paesaggi del lavoro, ma anche della fede nei tanti santuari che circondano Biella e le sue montagne.
Questo tratto di Panoramica, che qui chiamano tutti Tracciolino, offre ancora strepitosi orizzonti. Tra Andrate e Trivero, sono 65 chilometri che scorrono come un balcone montano aperto sulla pianura, per lunghi tratti sempre alla stessa quota di circa 1.000 metri. Nata quasi cento anni fa, la Panoramica Zegna oggi può diventare una proposta di turismo sostenibile e di prossimità davvero innovativo, in un paesaggio ideale per sperimentare nuovi equilibri tra lavoro, tempo libero, benessere.
Una breve ma sorprendente sosta alla Trappa di Sordevolo e arriviamo alla fine ad Oropa, dopo quasi 200 chilometri e 4.000 metri di dislivello.


Per chiudere il nostro anello preferiamo scendere lungo il percorso del vecchio tramvai per Biella, oggi dismesso, che seguiamo fino al Favaro. Un percorso, perfetto per la gravel, che sembra svolgersi in uno scenario da trenino elettrico: ponti in pietra, una curva elicoidale e pure una galleria. Dal Favaro ci stacchiamo per raggiungere il parco sulla collina della Burcina a Pollone. Noi lo abbiamo attraversato in estate, su stradine sterrate che scendono sul bel paese di Pollone, ma l’ideale è percorrerlo in autunno o, meglio ancora, a maggio, quando i rododendri sono fioriti.
Ancora poche curve e arriviamo a Biella, passando per il borgo medievale del Piazzo, con i suoi palazzi antichi e un’ultima strada acciottolata che ci porta al Piano, di fronte alla chiesa di San Sebastiano. Il nostro traguardo sono i giardini Zumaglini. Un consiglio rigenerante: un gelato con quattro palline di crema, crema, crema e ancora crema. Chiaro, se volete, provate anche altri gusti. Ma la crema che fanno qui, vi assicuro, è una delle migliori...
La nostra traccia è stato un filo (di lana!) che ha cucito insieme una dozzina di ambienti tutti diversi e davvero unici, collegandoli tra loro in una forma che, se la ripercorriamo nella mente e negli occhi, prima di risalire sul treno che ci riporta a casa, partendo dalla pianura e da Biella, passando dalle colline e dalle montagne per tornare ancora al piano, possiamo davvero vedere come una collana, oppure un cuore che sta al centro di quello straordinario spazio che è un vero e proprio central park tra le città di Torino e di Milano.

Testi
Andrea Rolando

Foto
Paolo Penni Martelli
Hanno pedalato con noi
Stefano Francescutti
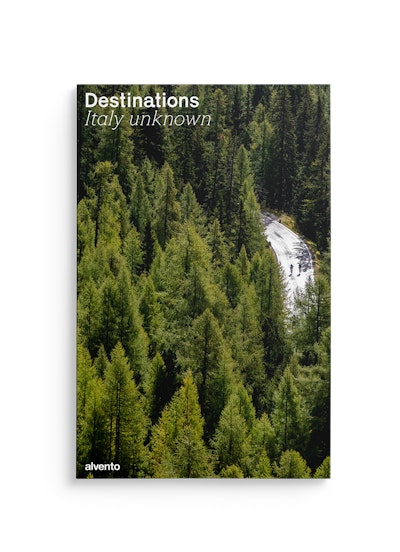
Questo itinerario lo puoi trovare sul super-magazine Destinations – Italy unknown / 1, lo speciale di alvento dedicato al bikepacking. 13 destinazioni poco battute o reinterpretazioni di mete ciclistiche famose.














