
Pedalata Granda
Alla scoperta della fascia pedemontana che fa da corona al capoluogo. 330 chilometri all’ombra delle grandi montagne.
Dislivello Totale
5384 m
Lunghezza totale
330 km
Durata
4 Giorni
C
Pedalata Granda
00
Intro
01
Da Cuneo a Dronero: ai piedi delle valli
02
Piccole e grandi scoperte tra Gesso e Stura
03
Su e giù per le valli
04
Dalla Certosa di Pesio a Mondovì e rientro a Cuneo
Alle prime luci dell’alba, il silenzio e le ombre della notte appena trascorsa avvolgono ancora via Roma: sfioriamo i tavolini dei bar, tutti lì, al loro posto, mentre le voci della giornata sono solo una fantasia. C’è giusto un camion dei netturbini che se ne sta andando. Uno sguardo alle bici e alle borse da bikepacking preparate la sera prima che saranno la nostra casa per qualche giorno, poi un saluto e un buon viaggio.
L’aria fresca ci toglie di dosso l’ultimo sonno mentre arriviamo al Parco Fluviale. Più iniziamo a far girare i pedali, più il profumo umido della campagna ci viene incontro e allontana la città alle nostre spalle. L’acqua è multiforme: fossi, canali irrigui, fiumi. Il Maira è quasi una guida verso Busca. La natura ci richiama alle stagioni: lungo i fossati che corrono accanto si sente le fragranza del gelso e del biancospino; i frutteti fanno quasi assaporare il gusto delle mele e delle pere che verranno. L’aria che profuma di tiglio ci resta addosso anche quando i tigli sono ormai lontani. Si comincia a sudare anche se il ritmo è senza fretta: è la giornata che si accende. Alla prima fontana si riempie la borraccia e ci si rinfresca il viso, quasi uno sprone che aiuta a salire verso la Colletta di Rossana.
La salita, lo sappiamo, è fatica e bellezza. Ce lo conferma, tra Busca e Rossana, la stele dedicata al passaggio del Pirata, nella tappa Bra-Borgo San Dalmazzo del Giro d’Italia 1999. Se chiudiamo gli occhi per un attimo, è come se sentissimo quella voce che diceva: «È partito Pantani». Questo ci basta per rilanciare la velocità.
Ancora salita e discesa per arrivare a San Costanzo del Villar. Ci aspetta, imponente, la riserva dei Ciciu del Villar. Ciciu, in piemontese, vuol dire fantoccio: i massi, emersi dalle millenarie erosioni dell’era glaciale, sono sagome giganti. Chissà quante ere si sono susseguite da allora, ma chissà anche quanti ciclisti sono passati di qui in una giornata di tarda primavera a cercare ombra e qualche goccia d’acqua zampillante. Giusto il tempo di riprendersi per poi salire verso San Costanzo al Monte e infine tornare a scendere.
Dronero è là in fondo. Ecco il Ponte del Diavolo, leggermente incurvato, a strapiombo sulla città vecchia. Qualcuno ci racconta la leggenda di quel sindaco che, per costruirlo, si accordò col diavolo. Il patto prevedeva che il diavolo, in cambio, portasse con sé la prima anima che l’avesse attraversato. Ma quel sindaco, appunto, ne sapeva una più del… diavolo e fece passare per primo un malcapitato cane, salvando i suoi concittadini di Dronero. Sarà suggestione ma, quando lo attraversiamo, un brivido ci corre lungo la schiena, anche se è una storia che raccontano di tanti ponti e di tanti (poveri) diavoli.


Il fondo stradale verso il Foro Frumentario è tutto ciottoli e l’effetto per noi ciclisti è lo stesso di un massaggio. Da qui passa la Gran Fondo Internazione Fausto Coppi: inevitabile alzare gli occhi in direzione delle sue mitiche ascese, il Colle Fauniera, la Madonna del Colletto… anche se davanti, visto che è ora di pranzo, abbiamo un piatto di ravioli e un bicchiere di Barbera. Ma è pur vero che da queste parti cibo e paesaggio vanno sempre d’amore e d’accordo.
Nel pomeriggio le strade ombrose ci vengono in soccorso nelle ore più calde. Bisogna arrivare a Bernezzo, quindi Cervasca, e infine a San Maurizio. In cima alla salita ci attende il Santuario: appoggiare la bicicletta al muro e fare due chiacchiere seduti sugli scalini della chiesa è una bella soddisfazione. Nel ritorno su Cuneo riattraversiamo di nuovo la campagna e ne catturiamo ancora gli odori e i suoni che ci erano venuti incontro a inizio giornata ma che ora ci sembrano come trasformati dalla luce del tardo pomeriggio.
Il mattino seguente scopriamo che il sole del giorno prima ha segnato i confini delle maglie e dei pantaloncini sulla nostra pelle. Usciamo dalla città lungo il viale degli Angeli, che prende il nome dal Santuario: dalla balconata sul suo lato orientale vediamo scorrere le acque del Gesso e della Bisalta. Lungo gli argini fluviali, i campi di grano dorati sfumano dal sole di prima mattina. La strada sembra un serpente fra i muri di mais e i canali verdi dell’acqua. Il Ferro da stiro – così, da queste parti, chiamano Cuneo per via della sua forma, incastrata e allungata tra Gesso e Stura – ce lo lasciamo in fretta alle spalle e pedaliamo in direzione di Borgo San Dalmazzo, un luogo che rende omaggio al passato, col Museo Memo4345 e col memoriale della deportazione.


La memoria serve anche a rammentare di non esagerare: la giornata è ancora lunga ed è solo la prima delle salite.
Spingendo sui pedali, ci dirigiamo verso Roccasparvera, accolti dalla frescura dei boschi di castagni, tra cui distinguiamo i primi ciuffi giallognoli del fiore. Davanti a noi si staglia Porta Bolleris, l’antico torrione quattrocentesco sotto il quale transitavano le merci da e per la Francia. A Rittana, un’indicazione che porta sul crinale che divide la Valle Stura e la Valle Grana, dice Paraloup, il nome della borgata che rimanda alla guerra partigiana e alla memoria dello scrittore Nuto Revelli.
Il caldo ormai sembra un ricordo, la pietra di cui sono fatte queste borgate sembra avere conservato il fresco dell’inverno per restituircelo. Sono i posti ideali per sfuggire alla calura, ma salendo per queste strade è sempre consigliabile portare con sé una giacca antivento. Una strada militare da Festiona, abbracciata dal fiume e dalla montagna, va verso Madonna del Colletto. Sono sei chilometri, in mezzo ai faggi: è metà mattino e nel silenzio del bosco si intuisce lo sgattaiolare di qualche animale al passare delle biciclette. Giunti in vetta, la vista abbraccia insieme Valle Gesso e Valle Stura. Alla fine di una fatica, il paesaggio ci racconta molto di più di se stesso.


Mangiamo qualcosa e poi scendiamo, giusto per sgranchire le gambe perché a Valdieri ci aspetta un’altra ascesa, quella verso Sant’Anna di Valdieri, un borgo che, una decina di anni fa, è stato portato agli onori della cronaca per essere stato rivitalizzato dall’iniziativa di sei donne. Grazie al loro coraggio imprenditoriale, l’insieme di piccole borgate di Sant’Anna di Valdieri offre oggi un esempio di intelligente e sensibile ricettività turistica con locande, appartamenti, case-vacanze, osterie e botteghe artigianali. A queste donne è riuscito il miracolo di far risorgere antichi valori contadini e di far rivivere tradizioni perdute. La montagna di una volta è tutta fra queste case.
Lassù, invece, intravediamo Terme di Valdieri. La roccia ai lati restringe la strada mentre la pendenza inizia a mordere. Arrivare è un sospiro di sollievo. Il gusto di questo posto? Un buon piatto di pasta di farina di segale condita con acciughe. Proprio qui vicino c’è anche il museo dedicato alla coltivazione della segale. Il pomeriggio lo trascorreremo qui, tra la natura e il cielo, magari approfittando per fare un salto al museo a cielo aperto dell’alpinismo. A sera, invece, dopo il tramonto, dormiamo a Sant’Anna. Nella notte la fatica scivola via. Ci resta addosso invece il senso e la bellezza di questi luoghi.
Se sai che le prime pedalate della giornata sono in discesa, la mattina inizia meglio. Giusto il tempo di controllare le bici e si può partire, facendo attenzione a coprirsi bene, perché all’alba l’aria è pungente. Arriviamo a Entracque, che si distende al sole nel cuore di una conca fra le acque di tre torrenti e la sua diga. Oltre che dal nome, il legame di questo paese con l’acqua è anche testimoniato dalle numerose fontane sparse per le vie. C’è anche un Centro Faunistico dedicato all’osservazione naturalistica del lupo. Salendo in vetta alla torre di osservazione del Centro si può ammirare tutta la valle. Tornare a scendere per la strada a curve che porta a Roaschia, piccolo borgo di pastori, è un gioco leggero. Da qui si sale per il passo delle Goderie. Attraversiamo una folta vegetazione e sul finale un tratto di sterrato in piano, solcato da qualche rivolo d’acqua che ci dà la sensazione di essere ciclocrossisti.
Una discesa tecnica ci accompagna a Vernante, paese a cui è legato il nome di Attilio Mussino, uno dei più celebri illustratori di Pinocchio: il che spiega il fatto che le facciate delle case siano piene di burattini e balene, murales dedicati alla memoria e al lavoro di Mussino... Tempo di un rifornimento brioche e cappuccino al bar, e siamo già sulla strada per Robilante, dove c’è un Museo delle fisarmoniche: quando è stata l’ultima volta che abbiamo sentito una fisarmonica suonare?
Ci pensiamo, mentre arriviamo alla salita di Malandre: il fiato è corto perché le pendenze si fanno elevate e noi abbiamo ancora nelle gambe le Goderie. Qualcuno, vedendo che ci fermiamo a riprendere fiato, ci racconta che nel 1977 anche qualche ciclista che correva su queste salite il Giro del Piemonte fu costretto a mettere il piede a terra. Questo un poco ci conforta.
Ma la salita non è finita. Continua, sterrata, dapprima verso Tetti Luchinet per poi farsi ancora più aspra. Tanto sforzo è però ripagato dalla meraviglia che ci attende ai Prati del Soglio o, come dicono qui, a Pra du Soi.
Quando il bosco si apre è l’incanto: dal grande prato si ammirano, come dalla platea di un teatro, le grandi montagne del Cuneese, un monumento di rocce e cielo, una sorta di Colosseo della natura. Ma anche un invito alla calma, alla tranquillità, le biciclette finalmente appoggiate sull’erba e i nostri sguardi a scrutare i profili delle vette.
Stasera ceneremo e dormiremo qui sotto, a Rosbella, al fresco delle poche case e di un paio di fontane. Nel 2000 qui era rimasto solo un abitante, oggi sono quindici, ma la pace è la stessa. L’unico rumore nel borgo, quando tutti vanno a dormire, è proprio l’acqua che scroscia nel torrente.
Anche questa mattina si scende subito ma è bene fare attenzione perché la picchiata verso San Giacomo di Boves è tanto veloce quanto tecnica e bisogna essere abili a guidare la bicicletta. Sembra quasi di prendere una rincorsa verso la successiva salita di Colletta Rivoira che, seppur breve, è di quelle che restano nei muscoli e si fanno sentire quando meno ce lo si aspetta. Verso San Giovenale, affrontiamo un misto di salita e discesa con anche alcuni tratti di sterrato: qui una gravel è l’ideale.
Procediamo verso la Certosa di Pesio: siamo a metà mattina e il monastero si nasconde tra sole e ombra. Qualcuno, all’esterno, sta sistemando i vasi di fiori e il prato. Ci sediamo sotto il portico, osserviamo, in silenzio. Lungo la scalinata che porta ai piani superiori è dipinta un’antica pianta della città di Cuneo e dintorni. Scorgiamo alcuni luoghi in cui siamo stati e ci sembra di rivederli. Ci orientiamo e capiamo dove saremo tra poco. Mangiamo un panino sui tavoli in legno fuori dalla Certosa: tutt’intorno foreste di abeti e le pareti della Punta Marguareis che svetta alta, coi suoi 2.561 metri.
Ripartiamo verso Pian delle Gorre, ancora salita e ancora sterrato, ancora vegetazione folta. La cima gioca quasi a nascondino, dopo ogni curva: ce la si immagina lì davanti, ma invece è sempre un poco più in là. In vetta ci si rifocilla con un buon piatto di gnocchi. Dopo un po’ di riposo scendiamo, passando dalla Certosa, direzione Mondovì. La piazza della città è una piacevole sosta. Per chi volesse spingersi ancora più in alto, ci sono gli 87 gradini e i 29 metri della Torre Civica del Belvedere: da qui è come se dessimo un ultimo largo abbraccio, dalle Langhe alle Alpi Cozie, al territorio che abbiamo attraversato in questi giorni.


Rientrando verso Cuneo, nel tardo pomeriggio, incrociamo il castello di Rocca de’ Baldi e poi l’Oasi di Crava-Morozzo, all’interno della quale scorre il breve corso del fiume Pesio, che nasce alle pendici del Marguareis, nelle Alpi Liguri e, dopo poco meno di 50 chilometri, sfocia nel Tanaro, presso Carrù. La riserva è la casa di aironi e anatre, come più avanti i laghetti artificiali di Tetto Lupo sono l’ultima suggestione naturalistica che sfioriamo prima del nostro traguardo finale.
I cuneesi dicono che, tutte le volte che si allontanano dalla loro città, gettano uno sguardo verso il Monviso, per sentirsi ancora per un poco a casa. E allora, stasera, anche noi, mentre rientriamo alla base, ne cerchiamo la sagoma, quasi a farci indicare l’ultimo tratto di strada da percorrere.

Testi
Stefano Zago
Foto
Daniele Molineris
Hanno pedalato con noi
Alice Pellegrino, Erik Rolando
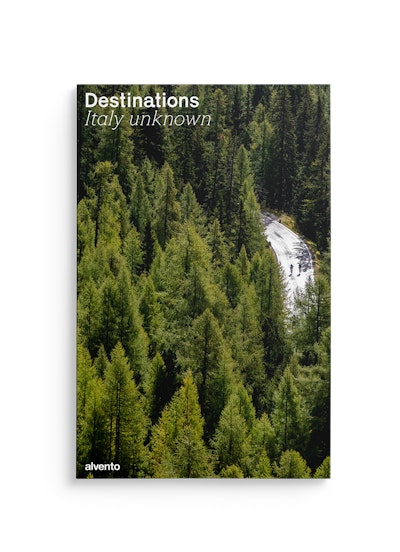
Questo itinerario lo puoi trovare sul super-magazine Destinations – Italy unknown / 1, lo speciale di alvento dedicato al bikepacking. 13 destinazioni poco battute o reinterpretazioni di mete ciclistiche famose.

















